Papa Giulio III

Notizie: (Monte San Savino, 10 settembre 1487 - Roma, 23 marzo 1555), Giulio III, nato Giovanni Maria Ciocchi del Monte fu il 221esimo papa della Chiesa cattolica e il 129esimo sovrano dello Stato Pontificio dal 1550 alla morte. Come Papa, Giulio III è ricordato più dagli storici dell'architettura e dagli amanti dell'arte, che dai teologi. Nominò Marcello Cervini, futuro papa Marcello II, bibliotecario vaticano, Michelangelo Buonarroti, capo degli architetti della fabbrica di San Pietro ed il compositore Giovanni Pierluigi da Palestrina, maestro di cappella della basilica vaticana. Inoltre potenziò la Biblioteca Vaticana e l'Università La Sapienza di Roma. Ultimo dei pontefici dell'alto Rinascimento, era il secondogenito di un famoso giurista, Vincenzo Ciocchi del Monte, e di Cristofora Saracini. Fu educato, secondo i dettami dello zio cardinale Antonio Maria Ciocchi del Monte, in un prestigioso oratorio presso il Laterano, dove ebbe come tutore il noto umanista Raffaele Lippo. Seguendo le orme del padre, in seguito, studiò giurisprudenza nelle Università di Perugia e di Siena. Quando, dopo la laurea, fu avviato alla carriera ecclesiastica, studiò teologia sotto il domenicano Ambrosius Catharinus e, nel 1513 succedette a suo zio come arcivescovo di Siponto (Manfredonia) in Puglia. Nel 1521 aggiunse anche la diocesi di Pavia. Durante il Sacco di Roma del 1527, fu uno degli ostaggi dati da Clemente VII alle forze dell'imperatore, e avrebbe potuto restare ucciso assieme agli altri a Campo de' Fiori, se non fosse stato liberato in segreto dal cardinale Pompeo Colonna. Fu creato cardinale prete nel concistoro del 22 dicembre 1536 da Paolo III, il giorno successivo ricevette la berretta rossa ed il 15 gennaio 1537 ricevette il titolo di San Vitale. Divenuto cardinale, però, fu preso di mira dal famoso Pasquino per le sue tendenze omosessuali. Nel 1545 fu inviato, insieme a Reginald Pole e a Marcello Cervini (il futuro papa Marcello II), come Legato Pontificio al Concilio di Trento, di cui aprì la prima sessione. Il loro compito era quello di scegliere gli argomenti di discussione e di sorvegliare i dibattiti. Al concilio fu il capo del partito pontificio in contrasto con quello imperiale. Nel 1547 fu l'artefice della decisione di trasferire il concilio a Bologna. Come ringraziamento per l'appoggio dei Farnese, Ottavio, nipote di Paolo III, venne immediatamente confermato come duca di Parma e suo fratello Orazio venne confermato nel Ducato di Castro. Entrambi conservarono le loro cariche, rispettivamente, di Gonfaloniere di Santa Romana Chiesa e di prefetto di Roma. Il 24 febbraio 1550 inaugurò, con l'apertura della Porta Santa della basilica di San Pietro, il X Giubileo, indetto da Paolo III, con la Bolla Si pastores ovium, e che si concluse il giorno dell'epifania del 1551 . Per favorire i pellegrini, riportò in vigore le disposizioni sul blocco dei fitti e sulla regolazione del mercato alimentare. L'afflusso dei pellegrini fu seguito da San Filippo Neri e dalla Confraternita della Santa Trinità. Nel concistoro del 28 febbraio 1550, stabilì delle regole per combattere il nepotismo e gli abusi della Chiesa. In questo concistoro negò la berretta a Pietro Aretino, che si aspettava una nomina data per sicura e tramontata con la morte di Paolo III. Ma solo quattro mesi dopo si ebbe uno dei fenomeni nepotistici più scandalosi: la nomina a cardinale del nipote adottivo Innocenzo del Monte (1532- 1577). Molti storici sono convinti che Giulio III nominò cardinale 'un figlio', ma molti altri affermano che il pontefice era molto legato affettivamente a questo ragazzo. Qualcuno afferma che la nomina cardinalizia fu il premio per la sua compiacenza. Contro tale nomina protestarono i cardinali più sensibili alla necessità di riforma dei costumi della Chiesa. Per i protestanti, comunque, non c'erano dubbi sulle motivazioni della nomina. In ogni caso, Innocenzo si rivelò uno dei peggiori cardinali che la Chiesa abbia mai avuto: rimasto senza guida alla morte del pontefice, fu coinvolto in una serie di fattacci e fu esiliato da molti dei pontefici successivi. Il 21 luglio 1550, inoltre, Giulio III diede una seconda definitiva approvazione alla fondazione della Compagnia di Gesù (i Gesuiti) nella bolla pontificia Exposcit debitum e, nel 1552, li incitò a fondare il Collegio Romano e il Collegio Germanico, destinato all'educazione dei giovani prelati tedeschi nella riforma della Chiesa in Germania. Nel periodo dal 1551 al 1553, Giulio III fece costruire sulla via Flaminia Villa Giulia, opera a cui lavorarono l'Ammannati, il Vignola e il Vasari. Il complesso della villa, in cui il Papa poteva dar sfoggio di lusso e sfarzo tali da sconvolgere le idee riguardanti la decenza ecclesiastica, si articola su due cortili separati da un ninfeo, che originariamente era un vero e proprio teatro d'acque. Internamente la villa è riccamente decorata con affreschi, stucchi, marmi policromi e statue. Tra le altre opere, sul soffitto di un portico è affrescato un pergolato ricoperto da viti, dove dei putti giocano con i rispettivi genitali. Joachim du Bellay il poeta francese al seguito del cardinale du Bellay, espresse la sua opinione scandalizzata in due sonetti della serie Les regrets (pubblicati dopo la scomparsa del Papa, nel 1558). Dopo la morte del Papa, la villa fu ereditata dal fratello Baldovino, ma, alla sua morte avvenuta nel 1557, fu confiscata da Paolo IV. Su richiesta dell'imperatore Carlo V, fece riaprire il Concilio di Trento sospeso da Paolo III nel 1548. La Bolla di convocazione fu emanata il 14 novembre 1550 ed il concilio fu aperto ufficialmente il 1º maggio 1551. Per rendere più comodo il viaggio dei prelati verso Trento, per la prima volta furono usate carrozze dotate di cinghie di cuoio con funzione di ammortizzatore. In questo periodo Giulio III si imbarcò anche nella Guerra di Parma, decisione per cui i prelati francesi non intervennero al concilio. Tuttavia erano presenti, per la Germania, gli arcivescovi elettori di Magonza, Treviri e Colonia. Vennero ripresi i lavori da dove erano stati abbandonati nel 1548 e vennero pubblicati i decreti sull'Eucaristia, sulla Penitenza, sull'Estrema Unzione e quelli riguardanti l'esercizio dell'autorità vescovile, i costumi del clero e la collazione dei benefici. Grazie all'intervento dell'Imperatore, dall'ottobre 1551 al marzo 1552, si presentarono anche alcuni inviati dei protestanti tedeschi: del principe elettore Gioacchino II di Brandeburgo, del duca Cristoforo del Wurttenberg, di sei importanti città imperiali della Germania Superiore e del principe elettore Maurizio di Sassonia. Tuttavia le trattative con loro non approdarono a nulla, perché furono poste condizioni inaccettabili, quali la sospensione e la ridiscussione di tutti i decreti già emanati, il rinnovamento dei decreti di Costanza e Basilea sulla superiorità del concilio sul Papa, e lo scioglimento dei membri del concilio dal giuramento di obbedienza al Papa. Il 28 aprile 1552, però, il concilio venne sospeso a causa dell'inasprirsi del conflitto tra Carlo V e Enrico II di Francia, che minacciava di trasformarsi in una guerra generale. Verrà riaperto dieci anni dopo. Poco prima dell'apertura dei lavori conciliari, Giulio III si fece trascinare dall'Imperatore in una guerra contro i Farnese, che, nonostante fossero sempre stati leali servitori dei pontefici, vedendo il territorio di Parma invaso dalle truppe di don Ferrante I Gonzaga, si erano alleati con la Francia. Il risultato fu che casa Farnese uscì dall'orbita imperiale e papale per entrare in quella francese. Don Ferrante I Gonzaga, governatore di Milano per conto dell'imperatore, occupò Brescello, zona d'influenza del cardinale Ippolito II d'Este, filofrancese, e si preparò ad assediare Parma. Orazio Farnese, aiutato anche dalle truppe francesi, fu battuto nei pressi di Mirandola, per cui Enrico II ordinò al generale Brissac di invadere il Piemonte. Questa manovra costrinse il Gonzaga ad alleggerire la pressione sul Ducato di Parma (settembre 1551) e fece sentire al pontefice il peso maggiore della guerra. Nel 1551 Giulio III inviò il nipote Gian Battista Del Monte ad assediare Mirandola, tenuta da un piccolo nucleo di francesi, comandati da Piero Strozzi ma l'assedio terminò il venerdì santo del 1552, con la morte del nipote. Giulio III cercò allora di riavvicinarsi alla Francia, ma le trattative furono rotte dalle eccessive pretese di Enrico II. Tuttavia, quando il Papa si accorse che l'imperatore era in gravissime difficoltà, i negoziati furono ripresi e, il 29 aprile 1552, si arrivò ad un accordo. Tale accordo stabiliva una tregua di 2 anni, trascorsi i quali Ottavio Farnese poteva accordarsi col Papa come meglio credeva, e la restituzione del ducato di Castro ai 2 cardinali Farnese. All'imperatore vennero concessi 11 giorni per accettare l'accordo. Carlo V ratificò l'accordo il 10 maggio. Ultimi provvedimenti e morte: nel 1555 Giulio III accettò la richiesta di Maria la Cattolica, a cui mandò come legato il cardinale Reginaldo Pole, di abrogare l'Atto di Supremazia inglese. In questo modo l'Inghilterra riabbracciò la fede cattolica, ma fu solo una tregua. Con l'ascesa al trono di Elisabetta I, infatti, il distacco della Chiesa inglese da Roma divenne definitivo. Giulio III, che soffriva di gotta da molto tempo, morì a Roma il 23 marzo 1555. Sebbene si fosse fatto preparare un sepolcro nella Cappella del Monte, nella chiesa di san Pietro in Montorio a Roma, la sua tomba si trova nelle Grotte Vaticane.
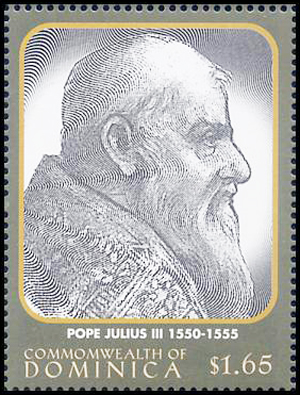
Stato: Commonwealth of Dominica Data: 05/09/2000 Emissione: Papi Dentelli: 13¾ x 13¾ Filigrana: Senza filigrana Stampa: Offset |
|---|
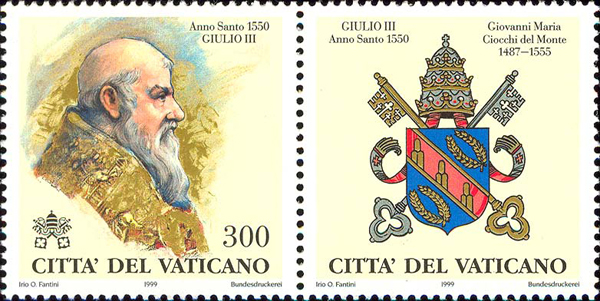
Stato: Vatican City Data: 23/03/1999 Emissione: I Papi e gli Anni Santi Dentelli: 13 Tiratura: 450.000 Stampa: Litografia |
|---|